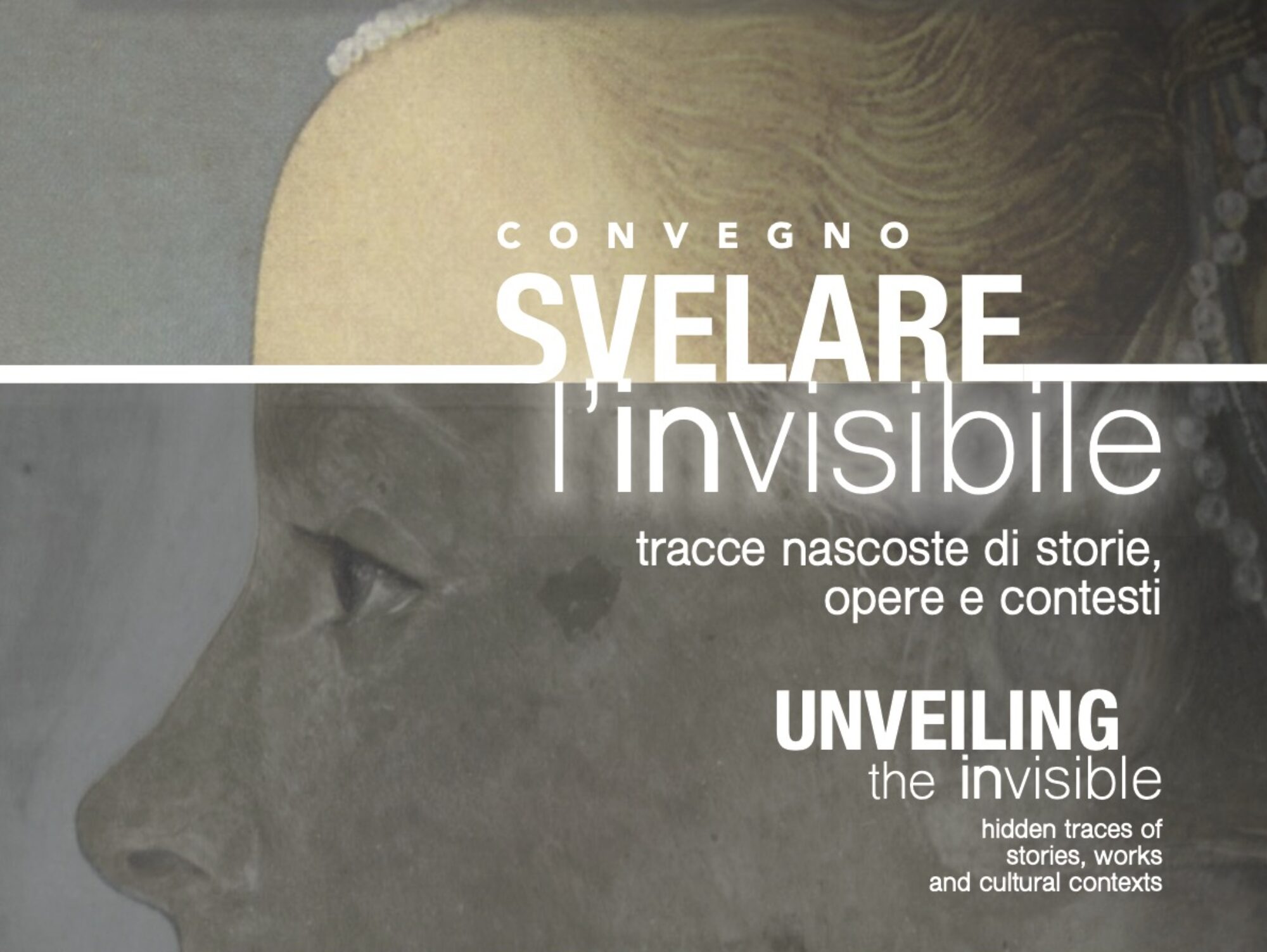Ai margini: realtà celate e storie alternative
Eliana Bridi (Università degli Studi di Padova)
Sotto la superficie: il sistema di smaltimento delle acque di Verona romana
La gestione delle acque reflue ha da sempre costituito un elemento essenziale e necessario al funzionamento e al benessere di una città, il quale si è tradotto nella costruzione organizzata e razionale di un sistema invisibile di canalizzazioni sotterranee, nascoste sotto le strade e i pavimenti delle case e degli edifici. Anche la città di Verona venne dotata, già a partire dagli anni che seguirono la sua fondazione come municipium e la costruzione del nuovo impianto urbanistico entro l’ansa dell’Adige, di canalizzazioni e cloache per lo smaltimento delle acque, come attesta l’iscrizione di Porta Leoni. Tuttavia, nell’ambito delle ricerche dedicate a Verona romana, poca attenzione è stata sinora rivolta all’impianto fognario urbano. Obiettivo del contributo è dunque quello di prendere in esame le evidenze riferibili alla gestione e allo smaltimento delle acque di scarico della città note da letteratura ed esito delle numerose indagini archeologiche condotte dall’Ottocento fino ad oggi, con lo scopo di tracciare un quadro di sintesi sull’impianto fognario del centro urbano antico. Oggetto di analisi sarà, in primo luogo, la distribuzione complessiva dei condotti e degli apprestamenti ad oggi noti, al fine di ricostruire l’estensione e l’articolazione della rete fognaria urbana. Il contributo si concentrerà poi sulle caratteristiche delle singole condutture, di cui verranno presentati e analizzati gli aspetti dimensionali e materico-costruttivi. Tali dati, opportunamente sistematizzati e combinati allo studio geomorfologico e altimetrico della città, costituiscono infatti la base per definire la gerarchia e il funzionamento dell’intera rete fognaria. In conclusione, il contributo intende riportare alla luce le strutture, in gran parte oggi non più visibili, appartenenti a un sistema che era, per sua natura, nascosto, ma la cui analisi potrà rivelare importanti dati sull’assetto urbanistico di Verona romana e sulle conoscenze e competenze tecniche degli ingegneri romani, nonché svelare preziosi dettagli sulla vita quotidiana della città.
Serena Bellotti (Università degli Studi di Udine)
Oltre il fotogramma
La mia presentazione si propone di spostare l’attenzione dalle immagini impresse sulla pellicola – quelle che verranno proiettate sullo schermo – alle informazioni esterne all’area del fotogramma, normalmente invisibili in proiezione ma fondamentali sia per il restauro del film, sia per ricostruirne la storia. Queste informazioni marginali (le annotazioni a china, la forma del mascherino, la presenza e le tipologie delle giunte, gli edge code del produttore della pellicola ecc.), propriamente dette in quanto si trovano tra le perforazioni ai bordi della pellicola, permettono infatti di ricostruire il testo filmico in modo più completo e di indagare le abitudini di ripresa o di stampa e montaggio dei diversi laboratori che hanno portato alla creazione del film. L’utilizzo di una scansione continua da bordo a bordo ha permesso di effettuare questo tipo di indagine (ovvero la fase di ispezione) anche in un momento in cui l’accesso ai materiali è stato limitato a causa del lockdown. Ad oggi, questa tipologia di scansione presenta dei limiti che rendono ancora ineludibile il ricorso al materiale analogico, come mostrerò nel mio intervento, attraverso esempi tratti da due casi di studio di ricostruzione filmica: La battaglia dall’Astico al Piave (Regio esercito italiano, 1918, 35mm, imbibito e virato, muto) e Spedizione Franchetti nella Dancalia (Mario Craveri, 1929, 35mm, b/n, muto).
Greta Boldorini (Università degli Studi di Padova)
Carla Lonzi e gli anni Novanta: appunti per una storia dimenticata
Critica d’arte ed esponente di primo piano del femminismo italiano e delle sue relazioni con l’arte, Carla Lonzi (1931-1982) è al centro, da più di un decennio, di una rinnovata attenzione che proviene sia da studiose e critiche d’arte, come per esempio Raffaella Perna, Lara Conte, Laura Iamurri, sia da artiste della nuova generazione, come testimoniato da alcune opere di Silvia Giambrone e Chiara Fumai. Emblematica della nuova visibilità di cui gode la figura di Carla Lonzi, innescata certamente, tra le altre ragioni, dalla ripubblicazione, su iniziativa della casa editrice et. al, di tutti i suoi testi che risultavano in gran parte ormai introvabili e fuori catalogo, è la realizzazione di diverse recenti mostre che hanno tentato, con modalità e finalità diverse, di verificare l’attualità del suo pensiero, quali per esempio Io dico Io (La Galleria Nazionale, 2021), Il soggetto imprevisto (Frigoriferi milanesi, 2019), Doing Deculturalization (Museioin, 2019). A metà tra il decennio degli anni Settanta e il rinnovato interesse che sta caratterizzando questa ultima decade, il decennio degli anni Novanta è stato fin qui tralasciato dagli studi. L’intervento intende quindi proporre una ricostruzione della ricezione negli anni Novanta del pensiero di Carla Lonzi cercando di individuare quale delle sue due anime e della sua duplice radicalità viene accolta: quella femminista o quella di critica d’arte. Attraverso un focus specifico sul contesto artistico, tralasciando quindi in questa sede quello prettamente femminista, si forniranno alcuni casi esemplificativi di tale ricezione: il libro rrragazze pubblicato nel 1996, un vero e proprio rifacimento del lonziano Autoritratto (De Donato, 1969); la sala dedicata a Carla Lonzi curata da Anne Marie Suzeau Boetti all’interno della Biennale di Venezia del 1993. Il contributo intende riannodare le fila di una parte rimossa della storia che accomuna Carla Lonzi, il femminismo e la storia dell’arte in Italia e che è meritevole invece di essere riportata alla luce.
Romina Zanon (Università degli Studi di Padova)
L’archivio dimenticato di Marcella Pedone: fotografie e filmati
di un viaggio identitario nei paesaggi di un’Italia perduta
Questa proposta s’inserisce in un articolato percorso di ricerca (nato nel 2018 in seno al Progetto di Sviluppo Dipartimentale “Traveling Identities” del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova, e attualmente in atto nell’ambito dello studio dottorale di chi scrive) atto a valorizzare e inserire nel patrimonio illustrativo della storia italiana contemporanea la produzione artistica della fotografa e cineoperatrice Marcella Pedone (Roma, 1919): uno studium demo-etno-antropologico formato da 170.000 fotografie a colori (dotate di un preciso apparato didascalico e conservate presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano) e 9.000 metri di girato in 16 mm, volto a trasporre in immagini l’identità italiana nel periodo 1950-1990. Nell’arco della sua lunga carriera, l’artista giunge a delineare, come forse nessun’altra fotografa e cineoperatrice della sua generazione, il ritratto completo di un’intera nazione nelle sue componenti paesaggistiche, sociali, economiche e folcloristiche. Pedone affronta in chiave umanistica ed etnografica la lettura del paesaggio e della società italiani in immagini capaci di testimoniare le profonde trasformazioni di un Paese che si lascia alle spalle un passato arcaico e rurale per rinnovarsi in un’identità modernizzata dal progresso tecnico-industriale determinato dal boom economico del miracolo italiano. In questa prospettiva, la ricerca – che ha il valore della scoperta in quanto rappresenta il primo tentativo di ricostruzione storico-critico della vicenda artistica di Pedone – ha l’obiettivo di storicizzare l’archivio fotografico e filmico dell’autrice nel sistema delle immagini contemporanee attraverso tangenze, rapporti, collegamenti interdisciplinari e di colmare le evidenti lacune storiografiche che hanno spinto nell’invisibilità la vicenda professionale della Pedone, nonostante i caratteri d’indiscutibile unicità che la caratterizzano: la produzione di immagini policromatiche di stampo neorealista in un tempo nel quale la fotografia era vestita esclusivamente di bianco e nero, e l’approccio metodologico della sua pratica documentativa che la conduce a viaggiare capillarmente su tutto il territorio nazionale per esercitare una professione all’epoca ritenuta prettamente maschile.
Chiara Andreatta (Università degli Studi di Padova)
Manufatti e culti domestici “invisibili”: le arule fittili. Due esemplari
pompeiani dagli scavi presso la domus al livello superiore del
Complesso delle Terme del Sarno (VIII 2, 21)
Nel ricco e complesso ventaglio di oggetti raccolti sotto l’etichetta di instrumentum domesticum, si inserisce una categoria di manufatti in terracotta, talvolta difficili da distinguere e riconoscere, che testimoniano particolari pratiche rituali legate al culto delle divinità tutelari della casa e della familia. Si tratta delle arule, manufatti riproducenti, in scala ridotta, grandi altari lapidei di forma parallelepipeda utilizzati per la combustione di piccole libagioni o di essenze profumate, nell’ambito di riti domestici di preghiera e offerta generalmente rivolti ai Lares, ai Penates o alla dea Vesta. La limitata attenzione storicamente riservata a tale classe di oggetti, tanto nelle esposizioni museali quanto nelle pubblicazioni scientifiche più datate, deriva dallo scarso pregio artistico attribuitigli e dalla difficoltà di una corretta identificazione, soprattutto nel caso di esemplari mutili e frammentari. Si tratta dunque di manufatti spesso “invisibili”, che raccontano di pratiche quotidiane tanto sfuggenti quanto essenziali e fondanti per la società romana. Il presente contributo intende illustrare tipologia, cronologia di produzione e probabile modalità di utilizzo di due arule mutile rinvenute nel corso delle indagini stratigrafiche condotte nel 2018-2019 a Pompei, presso la domus del civico 21, situata al livello superiore del Complesso delle Terme del Sarno. Tali oggetti, eccezionalmente conservanti tracce di policromia, costituiscono l’esito tangibile di pratiche cultuali di cui null’altro si conserva a livello di record archeologico e che per questa ragione sfuggono alle maglie della ricerca storico-archeologica, che deve necessariamente addentrarsi nella sfera dell’immaterialità e di una ritualità domestica difficilmente ricostruibile.Nel caso specifico dei due esemplari oggetto di studio, inoltre, questi rappresentano anche la preziosa testimonianza di fasi abitative non più osservabili, cronologicamente inquadrabili tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C., e di pratiche cultuali domestiche probabilmente esercitate da quanti abitavano all’interno delle due domus messe in luce al di sotto della grande abitazione attualmente visibile.