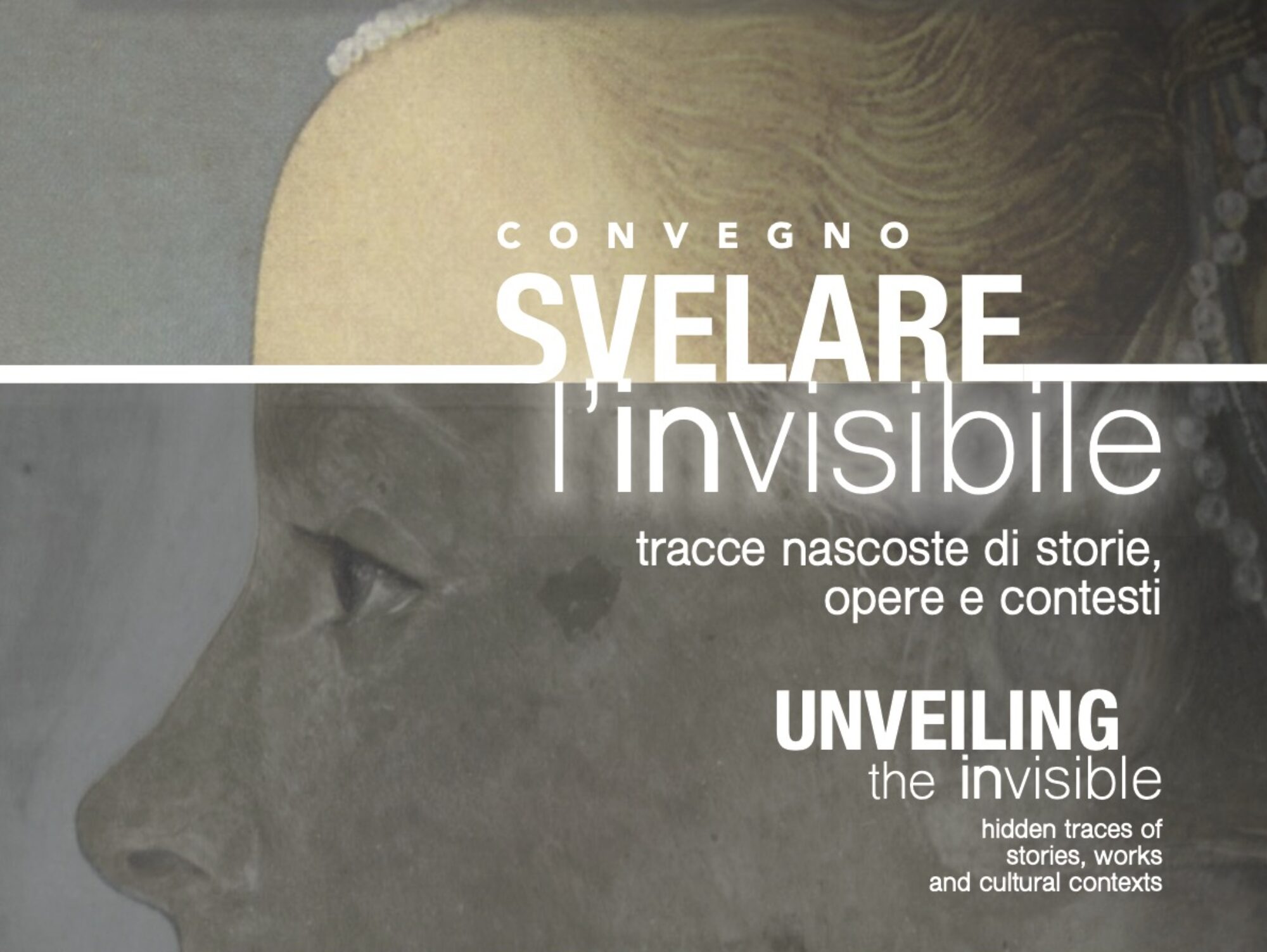Vivere nel paesaggio: svelare l’intreccio
tra comunità umana e ambiente
Mirko Fecchio, Maurizio Marinato (Università degli Studi di Padova)
L’invisibile nelle ossa: paleodieta e paleoeconomia nella Rab altomedievale
La comunità scientifica è ormai concorde che lo stile di vita e i cambiamenti nelle strategie economiche ed alimentari nell’età post-classica furono fortemente condizionati dalle trasformazioni ambientali e climatiche. Le ricerche multidisciplinari, applicate allo studio del materiale osteologico, stanno rivoluzionando i metodi e le prospettive della ricerca archeologica dimostrando come vi sia una situazione più complessa e fortemente regionalizzata rispetto a quanto indicato nelle fonti scritte. In questa sede si presentano i risultati di un’analisi archeozoologica condotta sul campione faunistico altomedievale (VI-VIII secolo d.C.) recuperato nel contesto urbano di Rab (Croazia) e quelli ottenuti dall’analisi antropologica e ad isotopi stabili su sei inumati del medesimo contesto. Le attività di scavo dell’antica Arbe sono dirette da circa un decennio dall’insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università degli Studi di Padova in collaborazione con il Dipartimento di archeologia dell’Università di Zagabria con l’obiettivo di mettere in luce la storia dell’isola sotto gli aspetti culturali, abitativi, sociali ed economici. L’assemblage faunistico indagato comprende un totale di 1403 frammenti ossei dei quali, il 73%, sono stati determinati grazie anche all’ottimo stato di conservazione del materiale. L’analisi archeozoologica ha permesso di delineare un quadro complessivo sullo sfruttamento dell’animale durante la fase altomedievale di occupazione del sito sia per le principali specie domestiche (caprovini, suini e bovini) sia per le risorse ittiche che rappresentano un’essenziale risorsa alimentare per gli abitanti dell’isola. La ricostruzione del complesso processo di abbattimento dell’animale combinato con le analisi ad isotopi stabili (δ13C e δ15N) sia su campioni di fauna che su inumati di sepolture altomedievali hanno implementato le conoscenze circa il consumo dei prodotti vegetali e, soprattutto, animali. La possibilità di incrociare i dati delle analisi biochimiche con lo studio antropologico e archeozoologico ha consentito di ricostruire alcuni aspetti sulle condizioni di vita nell’isola durante l’Alto Medioevo.
Francesca Tomei (University of Liverpool)
Svelare i paesaggi del mondo rurale greco tra agricoltura e produzioni ceramiche
Tradizionalmente, la ricerca sul mondo rurale greco in epoca classica ed ellenistica si è soprattutto concentrata sulla distribuzione e la funzione, all’interno del territorio, delle strutture agricole abitative (farmhouses) o adibite principalmente alla produzione primaria, trascurando quasi del tutto le attività artigianali legate alla manifattura della ceramica. Il contributo, tratto da una ricerca dottorale prossima al termine, ha come obiettivo l’analisi e la riscoperta del ruolo della produzione ceramica in ambito rurale greco e, in particolare, le sue connessioni con l’economia agricola, allo scopo di delineare il paesaggio complessivo delle attività (taskscape). Attraverso l’analisi di casi studio sia dalla Grecia che dalla Magna Grecia dove, nel corso degli anni, survey intensive in specifiche aree hanno portato all’individuazione di resti di abitati rurali e di fornaci di produzione ceramica (Berbati Valley – Argolide; Isola di Thasos; Chora di Metaponto), sono state considerate diverse tipologie di produzioni fittili per determinare le modalità di distribuzione dei prodotti stessi. L’integrazione di dati archeologici, geomorfologici e paleoambientali e la loro successiva elaborazione – tramite analisi spaziali – all’interno di un ambiente GIS (cost path surfaces e least-cost path) ha permesso la creazione di modelli esperienziali di movimento nel territorio, ad oggi invisibili; grazie a tali modelli è stato possibile stabilire la connessione tra i siti di produzione della ceramica, i piccoli centri e le fattorie isolate, nonché comprendere lo sfruttamento del paesaggio agrario all’interno della catena produttiva della ceramica. Per arricchire una ricostruzione di un paesaggio dinamico ormai invisibile è stato inserito il calcolo del costo energetico a cui necessariamente erano sottoposte le comunità per il trasporto degli scarti agricoli usati per alimentare le fornaci.
Agostino Sotgia (Università di Roma “La Sapienza”; University of Groningen)
Dai campi… alle città. Tecniche di landscape archaeology per riscoprire
l’antico agire delle prime comunità urbane
L’intervento prende le mosse dall’insegnamento di Italo Calvino secondo cui: «ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone» (Le città invisibili, 1972). Si presenterà una tecnica d’indagine attraverso cui ricercare nel paesaggio le tracce di quelle dinamiche socio-economiche (e quindi anche squisitamente politiche) che hanno influenzato l’agire antico dei diversi gruppi. Come caso studio, per dimostrare tutte le potenzialità dell’approccio ideato, si analizzerà il paesaggio agro-silvo-pastorale circostante gli abitati dell’Etruria Meridionale tra XII e IX secolo a.C. così da rivelare le dinamiche nascoste che hanno portato le comunità umane alla cosiddetta “Svolta Protourbana”: rivoluzionario fenomeno che ha portato all’ abbandono dei villaggi – in cui risiedevano da secoli – e alla fondazione delle prime città. L’approccio prevede l’uso delle tecniche di land evaluation (FAO) e di landscape arcaheology all’interno di una piattaforma GIS. Un modello del paesaggio antico, riportante i gradi d’idoneità delle diverse zone ad un loro uso agro-silvo-pastorale, è stato sviluppato – partendo dai dati archeobotanici e palinologici – per svolgere una simulazione dei comportamenti economici delle comunità tra la fine dell’età del Bronzo e l’inizio del Ferro. Attraverso l’analisi è stato possibile ricostruire l’invisibile agire delle comunità antiche sia dal punto di vista dell’economia primaria quanto da quello della conseguente consistenza demografica di esse. Grazie all’individuazione di territori specializzati in particolari produzioni, insediamenti in grado di produrre un surplus alimentare o viceversa siti non “auto-sufficienti” sono stati articolati e messi a verifica i modelli socio-politici suggeriti per l’Etruria, definendo una dimensione inter-villaggio fatta di reti di scambio, relazioni mutualistiche ma anche di rapporti competitivi e gerarchici tra i diversi insediamenti. Con l’analisi demografica, inoltre, è stato possibile indagare i fenomeni occorsi anche dal punto di vista delle persone coinvolte, sviluppando un metodo analitico facilmente applicabile – con lievi modifiche – anche ad altri contesti cronologici e/o culturali.
Pietro Agnoletto (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
Nuove prospettive di analisi dei film di famiglia. Il paesaggio marittimo
italiano attraverso lo sguardo del turista
Per ‘film di famiglia’ si intendono tutti quei filmati amatoriali destinati a un uso privato, che spesso ritraggono ricorrenze, eventi o vacanze. Tali documenti godono da alcuni decenni di un crescente interesse in ambito accademico, anche grazie al lavoro di recupero di archivisti e artisti che hanno trasferito queste memorie dal contesto domestico e privato a quello pubblico (Aasman, Montrescu-Mayes, 2019). L’approccio di indagine più frequentemente adottato prende le mosse da tematiche fondamentali, quali la memoria e la genealogia, gli aspetti sociali e storici, o le identity politics. Diversamente, in tempi più recenti, è stata delinata una prospettiva incentrata sul rapporto tra la produzione amatoriale e lo spazio urbano (Simoni, 2018). Da un lato, la ricerca qui presentata si allinea a questa medesima prospettiva, dall’altro, con essa si tenta di compiere un ulteriore passo valorizzando in particolare una tipologia di film di famiglia spesso tralasciata e ancora poco esplorata in ambito accademico: i film di vacanze (Locatelli, 2005). Con un approccio interdisciplinare, che tiene conto di geografia e media studies, sono state prese in esame oltre duecento bobine, oggi digitalizzate e conservate presso l’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa di Ivrea, prodotte tra gli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Ottanta da cineoperatori residenti in Piemonte e Lombardia. La ricerca ha consentito di esplorare, attraverso lo sguardo del turista, la profonda evoluzione urbanistica delle coste liguri avvenuta durante il boom economico del Secondo Dopoguerra, in seguito allo sviluppo edilizio legato al crescente fabbisogno di seconde case (dell’Agnese, Bagnoli, 2004). Non solo si è potuto evidenziare, anno per anno, il mutamento nel paesaggio, ma si è anche potuto osservare come sia mutato il rapporto del turista stesso verso lo spazio e la pratica turistica.
Ylenia Saretta (Università degli Studi di Padova)
Trasformazioni ed interventi strutturali svelati dagli eventi sismici: il caso
del terremoto Centro Italia 2016
L’architettura tradizionale dei centri storici italiani si caratterizza per fenomeni aggregativi più o meno complessi, esito di precise necessità, anche variate nel corso della vita utile degli edifici stessi. I materiali da costruzione sono tipicamente quelli disponibili in loco, assemblati secondo una regola dell’arte empiricamente determinata, risultando in apparecchiature murarie spesso caotiche e solai lignei flessibili. Nel corso dei secoli, il costruito diffuso ho mostrato la sua debolezza agli eventi eccezionali, specialmente a quelli sismici, cui da sempre i costruttori hanno fatto fronte sviluppando una “cultura sismica locale”, ossia realizzando presidi, tanto semplici quanto efficaci, per contrastare la tendenza al ribaltamento degli elementi strutturali. Nel corso del XX secolo, la tecnica de calcestruzzo armato, cui era riposta una estrema fiducia, ha sostituito le soluzioni più tradizionali, già compatibili con le strutture vernacolari, con sistemi rigidi e parti rifatte ex novo, secondo quanto prescritto dalle normative. Gli interventi erano concepiti per emulare i caratteri formali dell’architettura tradizionale o mettere a nudo elementi che normalmente non lo sarebbero stati, mentre la concezione strutturale originaria era completamente alterata. Il contributo intende, quindi, dimostrare come gli eventi naturali siano in grado di far emergere, purtroppo in maniera dirompente, le tracce nascoste di manomissioni e alterazioni subite dagli edifici storici, che tipicamente si configurano come vulnerabilità e fronti di debolezza nella capacità dell’edificio tradizionale a contrastare forze ed eventi inaspettati. Il sisma Centro Italia 2016 ha dimostrato l’inadeguatezza delle tecniche di intervento, utilizzate in maniera diffusa negli edifici vernacolari in muratura nelle zone sismiche della penisola, e l’urgenza di individuare soluzioni più compatibili e rispettose della sostanza materica preesistente, per evitare la perdita irreversibile degli edifici storici sia nel loro valore materiale che in quello immateriale.