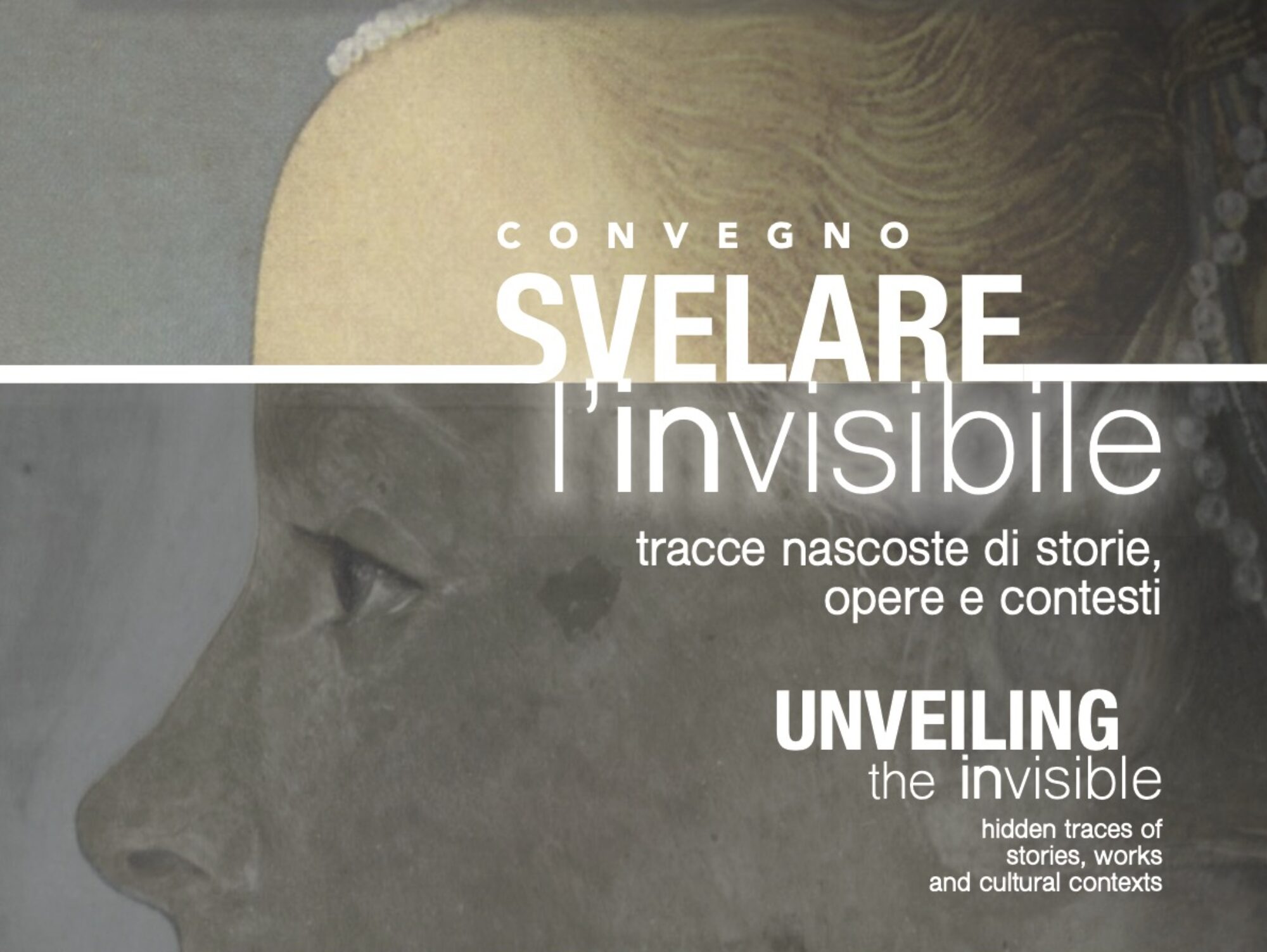Oltre i confini: leggere in filigrana il rapporto con l’alterità
Elisa Puppi (Università Ca’ Foscari)
Palazzo Zen (1533-1553): una porta d’Oriente a Venezia
Nel massiccio volume di palazzo Zen sito in Venezia si stendono, indietro nel tempo, le radici profonde e ramificate dell’opera architettonica: la storia intellettuale e ideologica del committente, le sue scelte e i suoi sodalizi culturali, la progressiva definizione degli strumenti linguistici dell’architettura della città. La critica per lungo tempo non si è interrogata sull’effettivo significato dell’edificio, relegandolo a un ormai anacronistico revival dell’architettura gotica, su volontà del committente; solo a partire dagli ’80 del Novecento, per merito degli studi di Ennio Concina, il dibattito critico si è ampliato. Oggetto della mia ricerca di dottorato, lo studio dell’edificio – edificato con le fortune della famiglia di Pietro Zen, uno dei più grandi mercanti e ambasciatori in Oriente e pare con una consulenza dell’architetto Sebastiano Serlio – svela la storia e la memoria della famiglia Zen, legata da tempi antichi al mondo arabo: le file di dromedari, palme e paesaggi persiani dei bassorilievi che adornano la cornice dell’intradosso e la facciata concretizzano materialmente l’incontro tra Oriente e Occidente. L’intervento proposto – alla luce dell’inedita documentazione rintracciata – intende dimostrare la volontà degli Zen di costruire una dimora che potesse autocelebrare l’identità e la memoria familiare, ma anche di porsi come speculum historiae di Venezia, porta d’Oriente, da sempre veicolo di sincretismo tra i due mondi.
Federica Bosio (Università degli Studi di Padova)
Frammenti d’Asia nella collezione di Lamberto Vitali
Lamberto Vitali (Milano, 1896 -1992) è acclamato per essere uno dei pionieri italiani nel campo della storia della fotografia, oltre che appassionato promotore dell’opera pittorica, scultorea e grafica di artisti moderni e contemporanei. Le preferenze e le inclinazioni teoriche di Vitali si riflettono nella sua collezione, che si configura come memoria esperienziale della tentacolare curiosità dell’artefice. I contributi scientifici editi si sono concentrati sugli interessi primari dell’intellettuale, tralasciando i suoi sconfinamenti verso Oriente. Il presente contributo intende svelare gli interessi circa l’arte dell’Asia orientale e meridionale maturati da Vitali tra gli anni Venti e Trenta del Novecento, seguendo le tracce nascoste nei risvolti della collezione, fra gli scaffali della sua biblioteca e tra le righe dei suoi scritti. L’intervento si propone di intraprendere sentieri “sotterranei” e non ancora percorsi, che rivelano le dinamiche attraverso cui alcuni dipinti cinesi confluiscono nella collezione e l’attiva partecipazione del critico alle esposizioni d’arte estremorientale organizzate nel capoluogo lombardo nel primo trentennio del XX secolo. I frammenti d’Asia presenti nella raccolta permettono inoltre di leggere in filigrana l’adesione di Vitali al movimento per l’inclusione delle arti orientali nelle riflessioni storico artistiche promosso, tra gli altri, da Paolo D’Ancona, Raffaello Giolli e Lionello Venturi. Nonostante i prodotti di matrice asiatica siano una parentesi nella speculazione di Vitali, essi testimoniano il tentativo di creare, nel microcosmo della sua collezione, una storia dell’arte corale e al plurale, dove i dipinti cinesi dialogano con le opere dei maestri primitivi e le sculture thai intessono legami formali con i dipinti di Morandi. Lo svelamento di queste prospettive collezionistiche e critiche, adombrate dagli interessi più patenti dell’intellettuale, è stato possibile attraverso lo studio di cataloghi, la consultazione di documenti d’archivio e il tracciamento dei dipinti cinesi appartenuti a Vitali in una raccolta privata milanese.
Giulia Luciani (University College Cork)
French Women Orientalists in the Maghreb, 1899-1929: Uncovering the Hidden
Strategies of Colonial Orientalism
This paper focuses on expatriate French Women Orientalists and the exchanges they had with their colonial contemporaneity between 1899 and 1929, investigating how the colonial context in which they lived and worked impacted on their aesthetics. It focuses on uncovering the strategies through which they commented on their colonial contemporaneity by staging their artworks as visual paradigms of ‘colonial Orientalism’ to reconcile the creation of Orientalist art in an assimilated and ‘domesticated Orient’, and deciphering whether these strategies reinforced or subverted colonial agendas. The paper presents further micro-research on artists such as Cécile Bougourd (1857-1941), Lucie Ranvier-Chartier (1867-1932), Marguerite Delorme (1876-1946), and Marguerite Tedeschi (1879-1970). They used a naturalistic style infused by the traditions of impressionism which, combined with representation of ‘Oriental’ subject matter, became a tool for France’s political intentions of representing conquered territories and lands. This study is foregrounded in the close visual study of paintings which depicted, but are not limited to, exterior scenes in urban and landscape settings. The paper employs a mixed methodology made up of feminist and postcolonial theory combined with micro-historical analyses, investigating artists’ role in the liminal space between Saidian ideology and individualistic artistic pursuit of cross-cultural learning. The contextualisation of their artworks and experiences in Algeria, Tunisia and Morocco could reveal the ways in which these artists have contributed to subvert or reinforce Orientalist narratives of Saidian reading. Connections between Orientalist art and colonial contemporaneity can be further explored through the gaze of these female artists compared with the historical configuration of North-Africa and artists witnessing urban and social changes carried out by the French colonial enterprise. The presences and absences in their artworks reveal their hidden comments on the colonial contemporaneity that the Maghreb was facing ― the redrawing and reorganisation of the coloniser/colonised divide.
Rui Ji (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)
La partecipazione della Cina alla Biennale di Venezia negli anni ‘80. Fenomeni nascosti
e cause dell’eterogeneità cinese nella storia dell’arte occidentale
L’arte contemporanea cinese d’avanguardia è spesso considerata nata tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 del XX secolo, radicata nel particolare contesto dell’urbanizzazione della Cina fortemente influenzata dal pensiero occidentale e che mostra un disallineamento con l’arte contemporanea occidentale, e coinvolta in modo controverso nella storia dell’arte occidentale, costruendo così il fenomeno della cultura eterogenea nella sua partecipazione all’arena internazionale. Nel contesto della post-nascita dell’arte contemporanea cinese, il caso delle due partecipazioni della Cina alla Biennale di Venezia negli anni ’80 con l’artigianato è al centro di questo articolo. Ripercorrendo i fatti storici della partecipazione dell’arte cinese alla Biennale negli anni ’80, questo articolo analizza le ragioni della mancata partecipazione dell’arte contemporanea cinese alla Biennale da quattro prospettive principali: la formazione di due linee di sviluppo tra l’arte cinese ufficiale e l’arte contemporanea cinese; il conflitto tra il sistema artistico ufficiale cinese e la forma di organizzazione dell’arte contemporanea cinese; la mancanza di comprensione dello stato attuale dell’arte sia in Cina che in Occidente; e gli elementi tradizionali cinesi hanno creato un’immagine stereotipata dell’atmosfera orientale nella produzione culturale cinese. L’analisi dei suddetti fenomeni e delle cause delle pratiche artistiche culturali eterogenee è utile per esporre lo sviluppo dell’arte contemporanea cinese e la complessa situazione di scambio tra Cina e Italia nascosta dietro la partecipazione della Cina alla Biennale di Venezia, fornendo così esperienze e riflessioni per la stesura di una storia dell’arte pluralistica, in particolare per la partecipazione di Paesi extraeuropei alle pratiche espositive europee, con il significato critico di tracciamento storico.