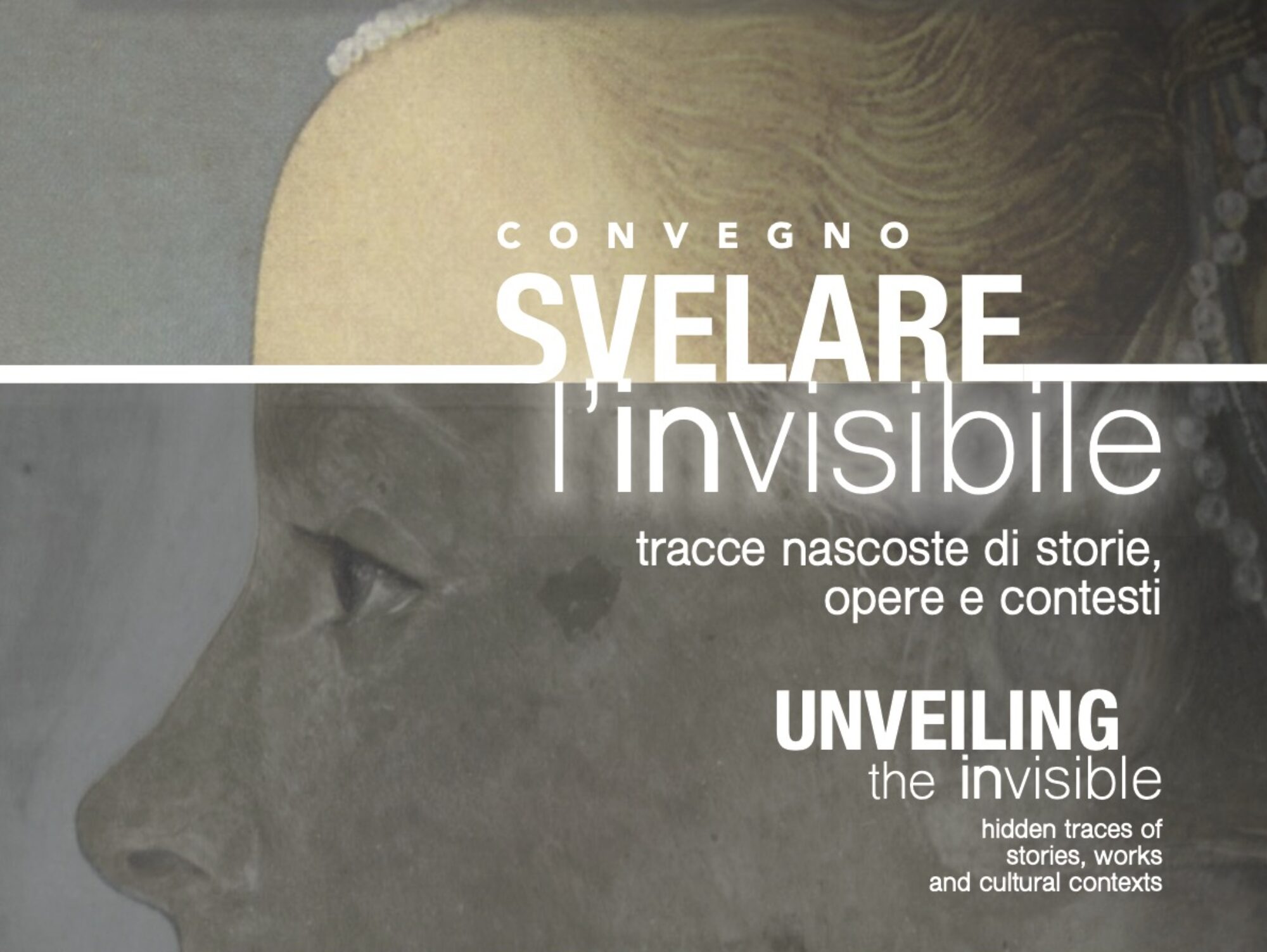Ricucire i frammenti: riscoperta e valorizzazione di opere e luoghi
Greta Plaitano (Università degli Studi di Udine; Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)
Archivi fotografici per le belle arti: il caso dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Tracce
e percorsi per valorizzare un patrimonio dimenticato
Senza contare il pionieristico lavoro di Nikolaus Pevsner, la storia delle Accademie di Belle Arti europee ha sofferto per diverso tempo di scarsa considerazione da parte degli studiosi, segnando spesso un rovinoso deterioramento del patrimonio storico-artistico custodito da queste importanti istituzioni pedagogiche (Pevsner, 1940). Come ricorda Antonio Pinelli, la causa principale di tale disinteresse è stata quella posizione egemonica benché limitata che ha a lungo negato all’arte «un radicamento istituzionale nella società contemporanea» e che le riservava piuttosto il compito «di fungere da critica radicale del modo di produzione dominante», esaltato in maniera significativa dalle Avanguardie a inizio Novecento (Pinelli, 1981). Nel contesto italiano una rivalutazione di queste istituzioni, del loro ruolo e della loro incidenza all’interno dei movimenti artistici è lentamente sopraggiunta verso la fine degli anni ’70 (Castelnuovo 1977), ed è stata affiancata solo in tempi recenti da una più complessa e necessaria mappatura dei patrimoni artistici – archivistici, fotografici, grafici, scultorei, pittorici – che esse conservano e che sono ancora oggi in attesa di un’adeguata opera di conservazione e valorizzazione (Cassese 2013). Inserendosi in questo quadro di ricerca la nostra proposta, in quanto catalogatore della fototeca storica dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e membro attivo della Società Italiana per lo studio della fotografia SISF, vuole pertanto portare all’attenzione del convegno i primi risultati del censimento dei materiali fotografici conservati presso l’Accademia di Brera. Questa intende così mettere in evidenza da un lato l’importanza didattica a lungo celata che fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo gioca il medium fotografico nell’insegnamento accademico nazionale e, dall’altro, attestare l’immensa opera di raccolta iconografica e documentaria delle principali scuole quali architettura, capitanata da Camillo Boito, storia dell’arte da Giulio Carotti, pittura da Cesare Tallone e scultura da Enrico Butti.
Andrea Chiocca (Università degli Studi di Padova)
Casa Arslan a Padova: una decorazione “svelata”
Capita spesso, nel corso di ricerche storico-artistiche, di imbattersi in storie dimenticate e oggi “invisibili”. È ciò che è avvenuto durante le indagini condotte da chi scrive per il dottorato di ricerca incentrato su Francesco Zugno e la bottega tiepolesca. In particolare, le fototeche dei grandi conoscitori del passato rappresentano una significativa raccolta di queste memorie. Nello specifico, dall’archivio di Antonio Morassi, nella busta che conserva il materiale relativo a Fabio e Giambattista Canal, sono riemerse alcune fotografie della Casa Arslan di Padova che conservava al suo interno, fino all’incursione aerea del 30 dicembre 1943, che ha interessato la città di Antenore distruggendo parte del palazzo, affreschi con una generica attribuzione alla scuola tiepolesca. Partendo dalle annotazioni manoscritte di Morassi si è giunti a identificare una piccola pubblicazione dal titolo Casa di cura del prof. Y. Arslan edita probabilmente intorno agli anni ’20 del Novecento da cui le fotografie sono tratte e che riportano alcune riproduzioni aggiuntive, dando una visione più completa dell’apparato decorativo presente nel palazzo a quelle date. Come è facile intuire osservando il materiale, si è davanti a una realizzazione di grande interesse e che di certo non rappresenta un episodio isolato nella città patavina. Infatti, nel corso del Sei e Settecento sono chiamati ad affrescare le residenze padovane alcuni tra i più importanti artisti della scuola veneta. In questa sede si cercherà dunque, grazie alle ricerche presso archivi e fototeche, supportate dal lavoro di connoisseurship, di avanzare nuove attribuzioni per l’apparato decorativo del palazzo e di far riemergere una vicenda quasi del tutto dimenticata, che consentirà di aggiungere un tassello alla conoscenza del grande patrimonio legato agli affreschi nei palazzi padovani nel Settecento, oggi depauperato da distruzioni, trasformazioni, stravolgimenti che si sono susseguiti nel corso del tempo.
Francesca Galasso (Università degli Studi di Pavia)
In-Visibile: la fruizione virtuale di luoghi scomparsi. Modelli, ambientazioni e simulacri digitali nella narrazione della memoria per una fruizione condivisa del patrimonio
La simulazione visiva, nell’arco di poco più di vent’anni, ha avuto un progresso impressionante sia per la capacità di raffigurare in modo dinamico sistemi, processi e modelli, sia per il grado elevatissimo di verosimiglianza che ha saputo raggiungere attraverso sistemi di riproduzione digitale [Galeazzi, 2018]. L’utilizzo di modelli tridimensionali come simboli visuali e veicolo di trasmissione di informazioni grafiche caratterizza la gran parte degli interventi legati alla valorizzazione del patrimonio culturale [Pietroni, Ferdani, 2021] confermando come i sistemi virtuali assumono nuovi signifcati e funzioni, amplifcando il valore del potenziale informativo delle applicazioni che ne derivano. Nel campo dell’archeologia, il dibattito scientifico si è concentrato sulla mancanza di un accurato protocollo metodologico riguardo la pratica della simulazione visiva digitale. Ciò è dovuto a diversi aspetti eterogenei della documentazione archeologica: la complessità dei contesti antichi, la loro rappresentazione e la natura stessa del materiale raccolto durante le campagne di scavo. Queste criticità si accentuano per quei contesti archeologici non più accessibili, la cui documentazione è avvenuta in tempi non recenti, effettuata attraverso l’uso di strumenti analogici e in condizioni d’urgenza senza un’indagine preliminare. La sfida maggiore nel raccontare attraverso strumenti digitali un sito archeologico oramai non più visibile è quella di cercare di tradurre in un linguaggio grafico adeguato le fonti, il materiale infografico e d’archivio non sempre ricollocabile spazialmente nello scavo. L’attività di sintesi delle informazioni verte a definire nuove strategie comunicative per la narrazione virtuale di luoghi non accessibili, attraverso lo sviluppo di applicativi virtuali in cui disegni e contenuti testuali diventano interattivi. La riscoperta dei luoghi di storia oramai invisibili attraverso lo sviluppo di percorsi di conoscenza virtuali serviranno infine per creare un nuovo network delle comunità locali, sensibilizzando i cittadini all’importanza della storia locale e dei valori condivisi. Per compiere questo lavoro di riconnessione col passato, è fondamentale decodificare i segni che la storia ha depositato sul territorio e lo sviluppo di applicazioni virtuali diventerà necessario per costruire nuovi legami con il tessuto urbano e nuove “mappe di senso” [Decandia, 2019, p.129] che consentano di contrassegnare lo spazio urbano di nuovi significati.
Benedetta Colasanti (Università degli Studi di Firenze)
Oltre l’illusione: le macchine del teatro Farnese di Parma (1628). Fonti per una
ricostruzione virtuale
«Fu fatta una dell’onde a vite, et posta in opera, fa effetto belliss.o». Così scrive Giovan Battista Aleotti in una lettera indirizzata al duca Ranuccio I Farnese. L’ingegno «dell’onde a vite» consiste nella scena del mare che apre e chiude l’opera-torneo Mercurio e Marte (1628): testo di Claudio Achillini, musica – perduta – di Claudio Monteverdi, scene e macchine di Aleotti e Francesco Guitti. Lo spettacolo va in scena in occasione del matrimonio di Odoardo Farnese e Margherita de’ Medici e dell’inaugurazione del teatro. Una messinscena esemplare per la storia del teatro barocco: dietro gli effetti meravigliosi della scenotecnica, della musica, della grande quantità di comparse, figuranti, torneanti e danzatori, si nascondono molteplici competenze professionali (pittori, muratori, architetti-scenografi). Dietro gli effetti illusionistici degli ingegni scenici, dietro il deus ex machina, si celano le nude macchine progettate da ingegneri-scenotecnici e sapientemente manovrate da macchinisti esperti. Se nel Novecento ci si serve soprattutto del legno o della plastica per ricostruire oggetti di studio non più esistenti, oggi le nuove tecnologie digitali forniscono strumenti utili alla restituzione storica. L’obiettivo del presente lavoro è quello di mostrare il processo di ricostruzione virtuale della macchina del mare, sintetizzabile nelle seguenti fasi: a) incrocio delle fonti: trattati (Nicola Sabbatini, Il corago), taccuini (Joseph Furttenbach, Pietro Paolo Floriani), corrispondenze, mappe e disegni conservati principalmente presso l’Archivio di Stato e la Biblioteca Palatina di Parma e la Biblioteca Ariostea di Ferrara; b) rilievo delle carte e realizzazione di un sommario delle misure; c) realizzazione della pianta e del prospetto del palcoscenico in 2D e in 3D; d) ricostruzione e animazione della macchina. L’analisi critica dei risultati terrà conto dell’illuminazione e del punto di vista privilegiato dei granduchi, modalità di fruizione derivata dalla teoria dei ‘piani in sfuggita’ del trattatista Guidobaldo del Monte.