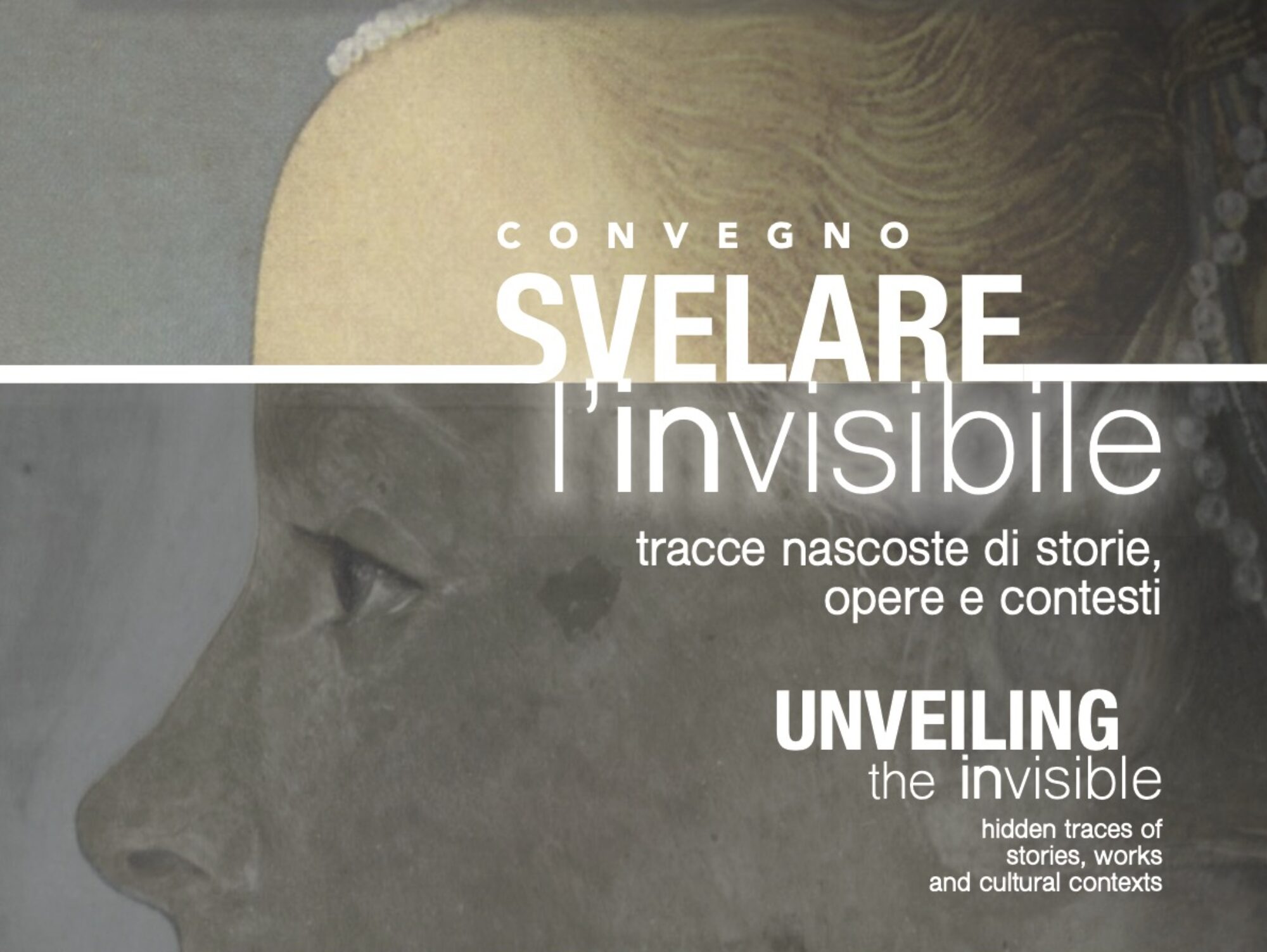Restituire alla conoscenza: rappresentazioni e ricostruzioni di realtà invisibili
Rachele Angela Bernardello (Università degli Studi di Padova)
Soft Boundaries. Tecniche e metodologie per rappresentare l’ipotesi
nel patrimonio storico costruito
Nelle ricerche in ambito storico, architettonico e ingegneristico volte alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio esistente, il concetto di digitalizzazione è ormai un fondamento che diventa strumento di studio tra gli studiosi stessi e di comunicazione con il pubblico finale. Raggiungere, infatti, gli obiettivi di promozione della conoscenza, assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione ad ogni tipo di pubblico sono determinati dall’uso di strumenti all’avanguardia, metodologie di lavoro efficienti, team di lavoro multidisciplinari e, infine, da una gestione proficua delle grandi quantità di dati da utilizzare e veicolare, il tutto sviluppato su base digitale. Emerge quindi l’importanza della capacità grafico-espressiva di quanto elaborato, non solo rispetto alla qualità delle immagini e degli altri output statici e multimediali, ma soprattutto in relazione all’invenzione e alla gestione di strutture spaziali complesse che consentono di rappresentare il tangibile e l’immateriale. In particolare, nello studio delle trasformazioni storiche del bene costruito, diventa fondamentale poter definire tecniche e metodologie che consentano di descrivere e quindi comunicare ciò che “non esiste più” con il corretto grado di ipotesi attribuito in fase di ricerca. La possibilità di definire Soft Boundaries nella restituzione informativa multimediale determina un confine comprensibile e chiaro, ma non disgiungente nella comprensione globale della trasformazione e delle ipotesi del patrimonio costruito. Il fine, quindi, è quello di implementare una perfetta conoscenza dei beni architettonici ed ingegneristici, anche attraverso strumenti informatici che consentono – attraverso il rilievo (laser-scanner, fotogrammetrico), la modellazione 3D interoperabile e la gestione informativa – una visualizzazione ed una interazione più immediata delle forme e delle strutture esistenti e non solo nello spazio virtuale.
Marco Argentina (Università degli Studi di Padova)
Decriptare i segni per restituire la danza
Ad oggi vi è una totale assenza di edizioni critiche coreiche. Di contro, esistono numerose messinscene di ricostruzioni coreografiche con intento filologico di balletti creati prima della comparsa e dell’uso del cinematografo. Ad alcune di queste ricostruzioni sono affiancate pubblicazioni a stampa delle soluzioni adottate. In tali pubblicazioni, però, non sono motivate scientificamente le ragioni sottese alle scelte compiute per la ricostruzione e, inoltre, questo modus operandi comporta che ogni altro studio sulla coreografia in oggetto debba ogni volta ricominciare da zero. Ad aggravare, poi, fortemente la lacuna nell’ambito della filologia della danza è il notevole analfabetismo dei professionisti e degli studiosi della danza relativamente alle partiture coreiche manoscritte, cioè ai testimoni che trascrivono, sulla pagina, le opere dei coreografi del passato mediante segni non sempre sistematizzati.Il presente contributo mira a colmare il vuoto segnalato presentando la realizzazione di un modello di edizione critica per lo spettacolo di danza, nello specifico riportando alla luce “Le Réveil de Flore”, un balletto classico creato da Marius Petipa nel 1894 su musica di Riccardo Drigo e rimasto “invisibile” alle scene per decenni. Della partitura “originaria” del Maestro francese a tutt’oggi rimangono le tracce solo sulla carta, cioè attraverso i simboli della notazione Stepanov, un sistema di scrittura della danza utilizzato a cavallo tra Ottocento e Novecento per registrare i balletti prodotti presso i Teatri Imperiali russi e odiernamente noto solo a pochissimi studiosi al mondo. Obiettivo dello studio qui proposto è, dunque, di svelare la creazione del maître de ballet marsigliese (messo in relazione con la musica del compositore padovano) attraverso la decriptazione di tali “tracce nascoste”, nonché di esporre e problematizzare le scelte metodologiche che contraddistinguono questo pioneristico lavoro di edizione critica da quelli delle secolari tradizioni ecdotiche letteraria e musicale.
Chiara Casarin (Università degli Studi di Padova)
Per una ricostruzione della concezione stilistica, formale ed estetica dei concerti per
violino di Giuseppe Tartini: un’opportunità per ripensare Dounias?
La figura e la produzione teorico-musicale di Giuseppe Tartini ricoprono un’importanza centrale nel panorama musicale del Settecento. Il “primo violino d’Europa” vanta infatti una straordinaria poliedricità di interessi culturali, un’appassionata missione didattica e una corposa attività compositiva, destinata quasi interamente a un solo strumento, il violino, e a un numero limitato di forme musicali. Tra i generi sperimentati il concerto solistico ricopre una posizione privilegiata anche in ragione della grande fortuna di cui gode questa forma nel XVIII secolo. Nonostante la notevole diffusione, le attuali conoscenze musicologiche sul concerto con strumento solista – contrassegnato da estrema varietà in termini di tipologia di partitura, organico strumentale, combinazione delle forze sonore, forma e stile – risultano frammentarie e tutt’altro che soddisfacenti. L’intervento si propone di ricostruire e contestualizzare, sotto il profilo teorico e musicale, la concezione stilistica e formale del concerto tartiniano, traccia “nascosta” e a oggi trascurata dalla storiografia. Punto di partenza è l’edizione critica di un corpus di ventisei concerti per violino solista e orchestra d’archi appartenenti al primo periodo compositivo di Tartini (1721-1735). L’indagine filologica permette di evidenziare come il compositore rielabori elementi della tradizione passata e coeva codificando un’espressione musicale originale e unica. Sul piano estetico, questo approccio porta a chiarire le connessioni tra i concetti formali e poetici modellati da Tartini e la cornice più ampia della sensibilità “illuminata”. Una migliore comprensione delle peculiarità della produzione di Tartini permette infine di discutere, quasi un secolo dopo, l’approccio metodologico di Minos Dounias alla cronologia tartiniana, i suoi risultati e i suoi limiti.