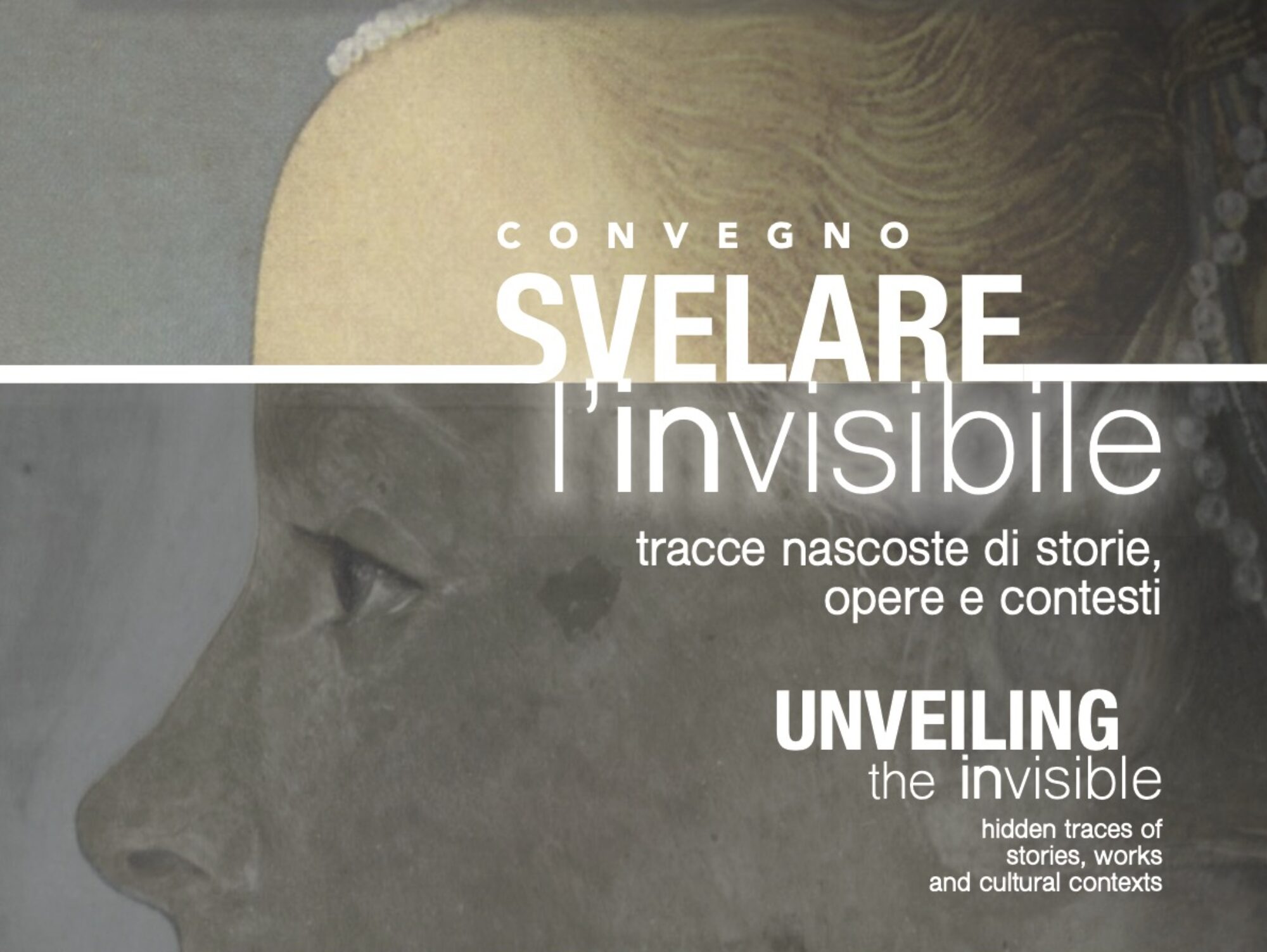Al di là della superficie: tecnologie d’indagine e pratiche esecutive
Francesca Daniele, Fiorenza Redi (Università degli Studi di Padova)
Per una possibile storia dell’atramentum
Il termine atramentum deriva probabilmente dal latino Āter, nero, e compare in un passo della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio in cui viene descritta la pratica di Apelle nel terminare le sue opere con una vernice scura per proteggere la pittura dalla polvere e dal sudiciume e per evitare che «lo splendor dei colori non offendesse la vista». Il medium del mitico pittore era ampiamente noto nel Rinascimento grazie alle molte edizioni di Plinio e alle parafrasi del suo testo, ma della sua effettiva applicazione, si sa poco altro: le versioni moderne della vernice altro non sono che possibili interpretazioni, essendo andata perduta la ricetta originale. L’utilizzo di vernici di finitura non è un fatto facile da indagare anche per la difficoltà di conoscere la composizione chimica dei materiali originali dei quali spesso non si trova più traccia a causa delle continue manomissioni e restauri che si sono succeduti sopra i dipinti nel corso dei secoli. Lo studio comparato di indagini documentarie e scientifiche si è però rivelato fruttuoso per ricostruire una possibile storia di questa vernice ormai invisibile: all’analisi delle fonti e delle documentazioni testuali che, in forma varia, hanno lasciato una traccia di questa esperienza estetica verranno correlati i dati emersi dalle ricerche scientifiche che in questi anni i laboratori hanno eseguito sui materiali costitutivi di alcune opere per tentare di capire se, e in che misura, gli artisti rinascimentali, e in particolare i coloristi della scuola veneziana, potessero intonare ulteriormente i loro dipinti applicando una vernice scura, anche solo con l’intenzione di emulare l’antico maestro. In tale ottica, la Dott.ssa Redi proporrà i risultati del suo ultimo studio sulle procedure di finitura dei dipinti di Jacopo Tintoretto (1519-1594) mediante una rassegna dei contributi tecnico- scientifici pubblicati a riguardo.
Elisa Ercolin, Diego Elia, Patrizia Davit, Monica Gulmini (Università degli Studi
di Torino)
Oltre il visibile. Un approccio interdisciplinare per la ricostruzione
della tecnologia di produzione della ceramica a vernice nera da Locri Epizefiri
Lo studio della ceramica a vernice nera rappresenta uno strumento conoscitivo prezioso per la ricostruzione dei sistemi produttivi locali. L’analisi congiunta dei repertori vascolari e delle pratiche artigianali consente di delineare un quadro di riferimento attendibile per la comprensione delle componenti culturali, sociali ed economiche della filiera. Un contributo fondamentale all’analisi di questi aspetti è giunto dalla progressiva apertura delle ricerche su questa classe ceramica verso l’archeometria: inizialmente incentrate sulla caratterizzazione chimica delle argille, negli ultimi decenni le indagini interdisciplinari si sono soffermate su specifici aspetti di tecnologia produttiva, con l’obiettivo di chiarire articolazione e organizzazione della catena operativa. L’intervento presentato in questa sede intende illustrare l’approccio elaborato nell’ambito del mio dottorato di ricerca per lo studio tecnologico della ceramica a vernice nera emersa nel corso delle recenti esplorazioni dell’Università di Torino a Locri Epizefiri (area del Casino Macrì). L’inquadramento crono-tipologico di più di 3000 attestazioni datate tra la fine VI e gli inizi del II secolo a.C. ha favorito l’analisi diacronica dei modi di produzione, con l’obiettivo di ripercorrere il processo di manifattura della classe ceramica dal “visibile” all’ “invisibile”. Lo studio autoptico del materiale è stato infatti affiancato da analisi in microscopia ottica finalizzate ad una prima classificazione dei corpi ceramici e alla raccolta sistematica di indicazioni inerenti la finitura superficiale dei manufatti e le strategie di distribuzione del rivestimento a vernice. Indagini micro-morfologiche e composizionali – sia chimiche che mineralogiche – hanno consentito di giungere ad una più completa caratterizzazione della produzione e di verificare se e in quale misura tra l’età tardo tardo-arcaica e il periodo ellenistico siano occorsi cambiamenti sistematici nell’organizzazione della catena operativa, con un’attenzione particolare rivolta alle modalità di lavorazione delle materie prime, alla gestualità sottesa al trattamento delle superfici, alla stima delle condizioni di temperatura e atmosfera applicate durante il processo di cottura.
Paola Improda (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”)
Indagini multispettrali alle opere di Colantonio nel Museo di Capodimonte
Colantonio (1420ca-1470ca) è stato il principale pittore napoletano del Quattrocento e il protagonista del Rinascimento meridionale, capace di sviluppare un linguaggio con chiare componenti legate allo stile fiammingo e alle sue varianti mediterranee. L’esperienza napoletana del pittore è testimoniata dalle tavole con ‘San Girolamo nello studio’ e ‘San Francesco consegna la Regola’, un tempo unite nella ‘cona degli Ordini’ sull’altare collocato all’ingresso del coro nella chiesa di San Lorenzo Maggiore, dalla ‘Deposizione di Cristo dalla croce’ proveniente da San Domenico Maggiore e dal polittico ‘San Vincenzo Ferrer con gli episodi della sua vita’, opere realizzate tra il 1440 e il 1460 ed attualmente nel Museo di Capodimonte a Napoli. Su questo importante corpus rinascimentale è in corso un approfondimento storico artistico con la messa a punto di una metodologia scientifica di documentazione visiva integrata dell’opera d’arte. Si intende dunque rendere nota una prima parte dei risultati ottenuti dalla documentazione acquisita in situ per mezzo di tecniche multispettrali, documentazione fotografica, riflettografia IR, con l’impiego delle tecnologie e delle competenze del laboratorio ReD del Dipartimento Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. Per conoscere i dipinti di Colantonio oltre gli strati visibili della pittura, osservando i disegni preparatori, i pentimenti e le modifiche apportate durante il processo pittorico, è stata eseguita la scansione riflettografica con la fotocamera Apollo di Opus Instruments. Sono state inoltre realizzate le analisi della fluorescenza a raggi X che hanno invece permesso di determinare la composizione elementale delle opere consentendo l’identificazione dei pigmenti e dei materiali utilizzati. Le misurazioni XRF sono state raccolte utilizzando lo spettrometro portatile Elio di XGLab Bruker secondo la modalità ‘punto’.
Federica Stella Mosimann (Università degli Studi di Padova)
Oltre il visibile: processi produttivi e tecniche esecutive svelati
da alcuni contesti pittorici di età romana
Il presente contributo intende focalizzarsi sull’analisi dei processi produttivi che stettero alla base della realizzazione degli arredi pittorici in età romana, a partire dalle “tracce nascoste” che ancora conservano gli intonaci dipinti sulla loro superficie. In particolare, l’analisi verterà sulle tecniche esecutive utilizzate per la realizzazione di uno stesso modello decorativo, quello “a modulo ripetuto”, approfondendone gli aspetti più prettamente tecnici ed esecutivi. A partire dalla lettura autoptica tramite osservazione diretta delle pitture di alcuni contesti significativi e dalla contestuale produzione di un’aggiornata documentazione fotografica di dettaglio, verranno presentate alcune delle principali tecniche esecutive che stettero alla base della produzione di grandi decorazioni pittoriche contraddistinte dall’applicazione del sistema decorativo a modulo ripetuto, sperimentate in differenti contesti edilizi, geografici e cronologici. A partire da questi nuovi dati, quindi, si rifletterà sull’esistenza di una prassi esecutiva canonica o sulla compresenza di tecniche diverse relative alla produzione dello stesso modello decorativo.