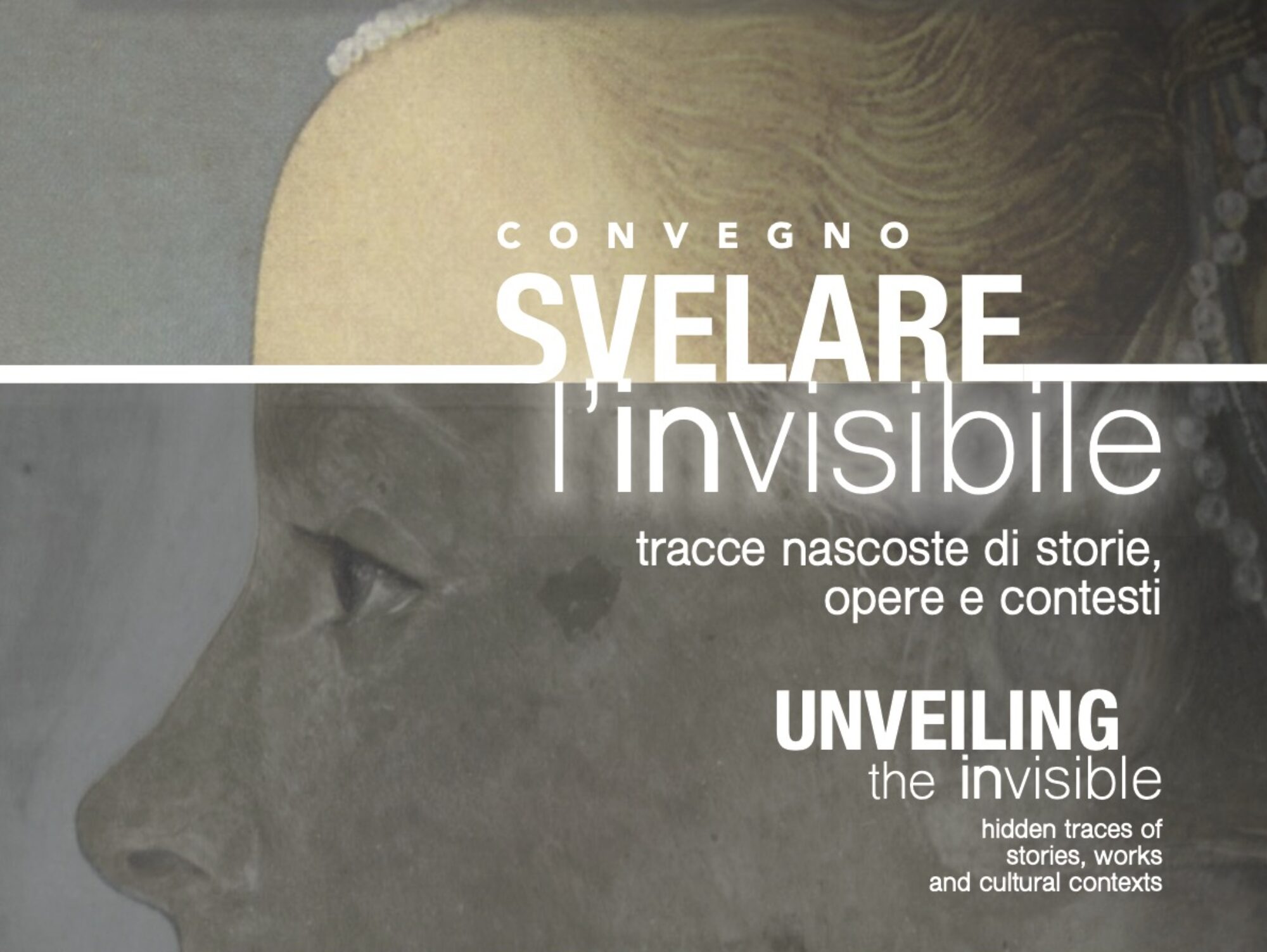Francesco Dragoni (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”)
Dispositivi visuali per la conoscenza specialistica, fra collezionismo ed
enciclopedismo. Il Dizionario figurato della vita musicale di ogni secolo
e di ogni nazione di Mario Bellucci La Salandra (1892-1966)
Mario Bellucci La Salandra (1892-1966), pioniere degli studi sulla Scuola musicale napoletana, realizzò nella prima metà dello scorso secolo una Raccolta iconografica di circa 16.000 immagini, per illustrare vari aspetti del sapere musicologico, adoperando disegni, calcografie, fotografie e frammenti di ‘stampa minore’. Il valore storico-documentale dell’insieme consente di ricostruire i legami intessuti dal suo autore, che dedicò alcuni fascicoli biografici a personalità emblematiche del clima intellettuale e ideologico del tempo (Alfredo Casella, Sebastiano Arturo Luciani, Raffaello De Rensis, etc.). Si rivela, in parallelo, il retaggio collezionistico dell’opera, connesso al fenomeno della ‘melomania’, considerando l’attenzione riservata a soggetti e temi della musica teatrale, nonché l’accurata realizzazione materiale di un apparato esteticamente godibile. Il disegno progettuale dell’archivio, conservato presso la biblioteca regionale di Foggia, ha sollecitato un’ulteriore riflessione riguardo all’affiorare di metodologie sperimentali per l’acquisizione e l’elaborazione dei saperi specialistici. Sono stati individuati e analizzati i processi di testualizzazione verbo-visiva adottati, decodificando la disposizione conferita al materiale iconografico attraverso i rimandi agli scritti editi e inediti dell’autore, come pure a specifici riferimenti bibliografici, grazie alla dimensione personale del relativo fondo archivistico e librario. È stato possibile, inoltre, riconoscere la peculiare strutturazione tassonomica del “dizionario”, aderente a specifici sistemi teorici e culturali, emersi nel corso del Novecento. La presente ricerca, quindi, propone un esempio di rivalutazione epistemologica degli archivi iconografici, considerando la componente ‘visuale’ non solo nell’accezione puramente informativa, ma anche in funzione discorsiva, secondo una prospettiva d’indagine interdisciplinare.
Anastasia Kozachenko-Stravinsky (Università Ca’ Foscari)
Igor Stravinsky’s The Soldier’s Tale through time and meanings
The Soldier’s Tale, or a theatrical work “to be read, played and danced,” was written by Igor Stravinsky with Charles Rameau in 1918. The twentieth century’s tragic events affected Stravinsky’s family brutally. But yet, the composer intended to create a work that could be related to any era and yet to 1918, to many nationalities and to none in particular. It is not a classical soldier’s story: a fearless man who “neither burns in the fire, nor drowns in water; neither fears the devil, nor the dead”, but rather an uneducated loser hero. And the Devil who is a one of the Zanni commedia dell’arte, the mischievous Harlequin. Stravinsky founded the theatrical musical work’s particular form, which surprisingly combined a tragic narrative reflexed through a satirical, comedic angle. It teaches us to read between the lines. For example, in South Africa in 1944, John Cranko choreographed a burlesque version of Stravinsky’s work, where at the same time, he demonstrated the pain of his comrades leaving for the war. In 1955, in Canada, “Bip the Clown” Marcel Marceau played the Devil and told by this character the family’s tragedy in Auschwitz. In 1968, in London, at the time of the worldwide protests, was presented a version for the very first time. In 1987, in Naples, director Roberto di Simone gave a circus performance regarding the fan boom of Diego Maradonna. In 2021, in Venice was a version that responded to the current pandemic’s life events. The variability of worldwide’s productions over the last 100 years provides an entire spectrum of new readings of the work created by Stravinsky. The use of humour helps to expose the dark side of human nature, and the reception of surrounding events is made possible by a cleverly constructed formula that incorporates music, text and image.
Silvia Mascia (Università degli Studi di Udine)
Emersioni d’archivio: il Totalrama come sistema nazionale di ripresa
di proiezione widescreen
La mia presentazione si soffermerà sull’analisi del sistema panoramico del Totalrama scoperto grazie allo scavo effettuato all’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa di Ivrea (TO), con l’intento di contestualizzarlo nel panorama di sperimentazioni schermiche e di guerra dei brevetti (Belton 1992, 2010; Vitella 2018) nel quale esso tenta di affermarsi. L’emersione di tale materiale d’archivio, depositato all’interno dell’ampio fondo Fiat, ha portato alla luce un dispositivo originale che parla non solo di un’evoluzione tecnica, ma si inserisce anche nella storia dell’industria cinematografica di inizio anni Sessanta e ne racconta un tassello. Difatti le pellicole, fino a quel momento mai studiate perché fuori formato standard, si presentano con un’immagine unica impressionata orizzontalmente per tutta la lunghezza, senza interlinea e senza tagli. La loro analisi e la ricerca storica hanno portato alla scoperta del sistema del Totalrama, brevettato dall’Ingegnere italiano Vico D’Incerti con l’intento di innovare la tecnica cinematografica. Esso prevedeva infatti l’utilizzo di una sola camera sia per la ripresa che per la proiezione, ottenendo un flusso di immagini a 360° che dava vita a uno spettacolo immersivo. Il progetto del film in Totalrama è, a tutti gli effetti, quello che in una prospettiva media archeologica viene definito un dead end. Termine con il quale ci si propone di studiare tutti quei prodotti mediali che non hanno avuto successo, che sono “morti” prima di essere stati completati, che sono stati abbandonati, trascurati, dimenticati. In questo modo viene data attenzione a quelle strade interrotte che sono però interessanti da riscoprire e che ci parlano di una storia più grande (Elsaesser 2016; Huhtamo, Parikka 2011).
Chiara Pupella (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
Architetture medievali fortificate e paesaggi rurali del potere:
il contesto dell’Alto Brembo in alcuni casi studio
Il territorio della Valle Brembana rappresenta un contesto privilegiato per lo studio dell’edilizia fortificata bassomedievale, intesa come presupposto di affermazione del potere su vari livelli, non soltanto di personaggi di alto rango, ma anche di casate minori di ambito rurale. L’architettura diventa il manifesto del ruolo rivestito nella società e costituisce un testimone chiave per acquisire informazioni sui modi dell’abitare e del vivere una determinata realtà. Proprio laddove si vuole dichiarare la propria supremazia a difesa del territorio, emergono tracce architettoniche significative. Dalla ricerca sul campo a quella bibliografica e d’archivio è possibile censire e ricostruire sia le testimonianze concrete ancora oggi visibili sul territorio, sia le tracce nascoste di contesti bassomedievali fortificati. Diversi sono i casi studio che evidenziano la varietà di strutture fortificate sparse su tutta la valle, in particolare nel territorio dell’Alto Brembo: il contesto di Averara conserva almeno due strutture (e probabilmente anche una terza), la Torre della Fontana e la Torre sopra la Corna, poste in posizione sopraelevata sulla valle, che costituivano un sistema difensivo e di avvistamento per il controllo del fondovalle; nel territorio di Mezzoldo, a circa 1350 m s.l.m. si trova la località Castello, ricordata in vari documenti a partire dal 1653; anche Cusio Superiore e Piazzatorre indicano la presenza di zone con il toponimo di “Castello”; per i comuni limitrofi di chiusura dell’Alta Valle, Lenna e Piazza Brembana, le fonti attestano due torri con probabile funzione di difesa del fondovalle.
Paola Ricchiuti (Università degli Studi di Bergamo)
Il Labirinto “invisibile”: Chiesa di San Savino a Piacenza
Tra tarda Antichità e alto Medioevo il labirinto acquisisce nuova significazione entrando in un contesto cristiano che vi vede un percorso destinato a morte ma anche a nuova vita, dunque a resurrezione. Esso – però – nella sua veste di rappresentazione grafica tra V e XI secolo d.C. scompare per riemergere nel secolo XII d.C. in forma musiva su pavimenti di chiese italiane. Proprio a Piacenza, nella chiesa di San Savino, consacrata nel 1107, è rimasto testimoniato sul pavimento della navata centrale un labirinto che doveva ricalcare lo schema di quello di San Michele a Pavia, circolare con al centro il Minotauro. Ne rimane citata la scritta che lo accompagnava. Al movimento tortuoso labirintico si connettono richiami all’idea ciclica del tempo: il complesso di mosaici superstiti nella chiesa di San Savino gravita attorno al ciclo dei mesi e alla ruota del Tempo.
Francesca Rigato (Università degli Studi di Milano Statale)
I teatri sotterranei milanesi tra la fine del XIX secolo
e la prima metà del XX
A Milano tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo sono nati molti teatri, con la configurazione – all’epoca innovativa – della sala da spettacolo sotterranea. L’aspetto più interessante, su cui questo poster si vuole concentrare, è delineare come le diverse sale, tutte presenti nell’area di qualche chilometro, fossero collegate tra loro, attraverso spettacoli, trust, compagnie e attori e fondassero un vero e proprio circuito teatrale (sotterraneo e differente da quello dei teatri d’arte) e una rete comunitaria di spettatori ed eventi, come se sotto la città ci fosse un altro mondo brulicante e attivo. Dove è finito oggi quel proliferare di teatri del centro milanese? Queste sale, tutt’ora esistenti, sono state trasformate in altro. Una casa di moda, un bar, un negozio, un parcheggio, costruiti per l’appunto dove prima c’era un teatro, ma se si osserva attentamente si possono ancora trovare delle tracce, apparentemente invisibili, di quello che esisteva prima della trasformazione. Ecco dunque che svelare l’invisibile, il non più noto, diventa necessario per la storia non solo teatrale ma anche per quella con la S maiuscola e porta a comprendere come un’intera società vivesse e partecipasse alla vita cittadina per quasi un secolo. Il poster delineerà e riporterà alla luce la conoscenza dei teatri sotterranei milanesi tra cui, citandone alcuni, l’Olimpia, l’Eden, il Diana, il Sant’Eramo. Lo studio proseguirà mostrando la connessione di queste sale, legate tra loro non solo da spettacoli, compagnie e prime teatrali ma anche dallo stesso destino, cioè la trasformazione di questi edifici inizialmente in cinema, in seguito in ex luoghi di cultura e quindi spazi di commercio e di consumo, restando tuttavia parte integrante di una comunità odierna che continua a frequentare i medesimi posti trasformati.
Claudia Sorrentino (Università degli Studi della Tuscia)
Storie di archeologia invisibile. Scoperta e ricomposizione
di un archivio fotografico di Soprintendenza
In ambito archeologico, la ricerca sul campo ha da sempre posto grande accento sulla rilettura delle indagini svolte nel passato, in particolare quelle effettuate dalla seconda metà del XIX al terzo quarto del XX secolo, periodo in cui le attuali metodologie di lavoro erano ancora in fase di definizione. Tali scavi sono giunti a noi solo parzialmente nella letteratura dell’epoca e per tale ragione gli archivi assumono oggi una fondamentale importanza, conservando al loro interno le relazioni scientifiche e i giornali di scavo spesso corredati da un importante apparato di fotografie, caratterizzate da un duplice valore storico-documentario, sia dal punto di vista antiquario sia della ricerca archeologica. Realizzato e implementato con un’evidente funzione di servizio, tale patrimonio costituisce oggi un prezioso serbatoio di dati non solo per le ricerche di ambito strettamente archeologico, ma anche per le indagini legate alla stessa tutela dei Beni Culturali. Non è raro, infatti, rintracciare negli archivi fotografici l’unica documentazione disponibile in merito a precedenti studi riguardanti testimonianze materiali andate ormai perdute, come nel caso di siti archeologici non più visibili, di antiche strutture inglobate all’interno di fabbriche moderne, di manufatti monumentali demoliti, ma anche di reperti dispersi dopo il rinvenimento o immessi nel mercato clandestino. Se si considera poi che nella maggior parte dei casi i materiali conservati sono inediti, gli archivi fotografici di archeologia, quale che ne sia oggi l’istituto detentore, offrono interessanti occasioni di studio e di valorizzazione della stessa documentazione, al fine di pervenire ad una ricostruzione delle vicende storico-archeologiche che hanno interessato il territorio oggetto di studio. La ricerca si propone di affrontare il tema degli archivi fotografici di archeologia partendo dal caso dell’archivio fotografico costituito dalla ex Soprintendenza alle antichità dell’Etruria meridionale assegnato con la Riforma Franceschini al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia dove si trova ancora oggi.
Gianantonio Urbani (Università degli Studi di Padova)
Indagini di microarcheologia presso il monte Tabor in Israele
Il contesto del monte Tabor presso la regione della Galilea in Israele, con una continuità di frequentazione almeno dal II millennio a.C., è stato finora indagato in maniera parziale. Le prime attività di rimozione dei materiali furono sterri effettuati a metà del XIX sec. e gli studi del contesto e della specificità del Tabor in seno all’archeologia delle terre bibliche furono intrapresi solo verso la fine del 1800. Con la costruzione della basilica moderna che ricorda il fatto evangelico della Trasfigurazione del Signore Gesù (1920-1924) furono redatte delle planimetrie ed una sistemazione generale delle antichità, con poca letteratura a riguardo. Uno degli elementi importanti per determinare la funzione di culto in questo luogo nell’antichità è l’analisi del toponimo Atabyrios/Itabyrios, da cui prende il nome la stessa montagna, dove probabilmente si era diffuso il culto a Zeus, con lo specifico appellativo di Atabyrios. Lo scopo di questo poster è rappresentare le azioni che sono in essere nell’area sommitale del monte Tabor di proprietà della Custodia di Terra Santa e le possibili relazioni con altre località della valle di Esdrelon/Jizreel. Da novembre 2021 a febbraio 2022 sono stati operati dei saggi di scavo in tre aree specifiche della proprietà, in accordo con l’Israel Antiquities Authority. Nello stesso tempo sono stati raccolti e campionati alcuni materiali che sono in corso di analisi presso il laboratorio del Kimmel Center for Archaeological Science e del D-REAMS Dangoor Research Accelerator Mass Spectrometer for Radiocarbon Dating (Weizmann Institute of Science – Rehovot – Israele) applicando i principi di microarcheologia in vista di determinare una datazione dei contesti e quindi una prima ipotesi ricostruttiva delle diverse fasi di occupazione.
Francesca Vella (Università degli Studi della Tuscia)
I diritti negati in alcune ricerche artistiche dell’area post-sovietica
Oggetto di questo intervento è il delineamento di un quadro delle ricerche portate avanti dagli artisti provenienti dall’area dell’Est Europa in risposta alle discriminazioni operate nei loro confronti. Questioni relative alle diversità culturali, all’invisibilità e all’alienazione, sono divenute una costante per molti di questi artisti proprio a partire dal 1989. Il dibattito circa il diritto all’immagine, al riconoscimento, alla visibilità non è stato sempre fluido, ed ha rappresentato una ricerca spesso faticosa da parte degli artisti: testimoni in prima persona delle ostilità, osservate e restituite secondo una molteplicità di prospettive. È ciò che accade con i minatori di Igor Grubić in Angels with Dirty Faces o con i personaggi dimenticati, gli eroi civili, del popolo, di Was ist Kunst Bosnia and Herzegovina – Heroes 1941-45 del collettivo sloveno IRWIN o – ancora – con le vite quotidiane dei rifugiati che
tentano di attraversare i confini dell’Unione Europea in Newsreel 65 – We Have too Much Things in Heart… di Nika Autor. Emerge nel loro approccio la necessità di rendere le differenze come un qualcosa di non discriminante, privo di stigmatizzazioni, affinché possa svilupparsi un contesto di accettazione – senza respingimenti – nei confronti proprio dei diritti, i quali non devono essere normati sulla base dell’identità. In questa prospettiva si collocano riflessioni come An artist who cannot speak English is no artist di Mladen
Stilinović o I Love Europe, It Does Not Love Me Back di Oleg Kulik, in cui l’artista veste i panni di un cane rabbioso, che tenta un’emancipazione da una condizione di esclusione. Un tentativo di riscatto per la negazione dell’identità storica e di una rappresentanza politica è anche quello che propone Sislej Xhafa alla XLVII Biennale di Venezia con il suo Padiglione albanese clandestino. Infine, Adrian Paci con la storia di Klodi circa i diritti umani e di dignità.